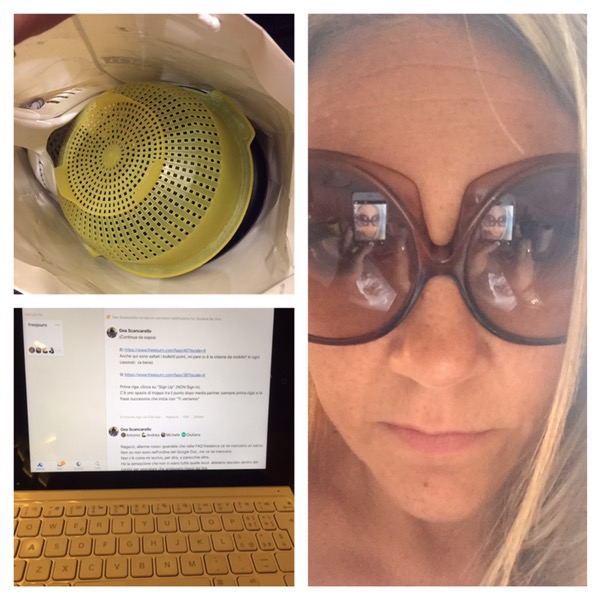Dispacci, India – Chennai #4
In tutti i Paesi asiatici il clacson è usato con una certa libertà: più che un segno di avvertimento, un’allerta permanente. Il che, peraltro, rispecchia la natura del traffico.
In India tuttavia è qualcosa di più, quasi un segno di mascolinità: più suoni, più sei uomo.
Ed è così che oggi l’autista del bus Chennai-Tiruvannamalai, sul quale incautamente ci siamo sedute in prima fila, mi ha totalmente stordito: e non basta che abbia messo prima gli auricolari e poi addirittura i tappi per le orecchie, sono arrivata a destinazione frastornata come mai mi era successo per il rumore, con quel senso di nevrastenia da il prossimo che dice una sillaba lo meno che deve essere proprio la spiritualità che tutti vengono cercando quaggiù.
(Il prossimo, per la cronaca, era l’autista di un tuc tuc che dopo tre minuti di contrattazione serrata sul prezzo mi ha accolto dandomi una gomitata nell’occhio con l’orzaiolo, ma la divinità hindù deve averlo protetto dalla mia possibile reazione).

Dispacci, India – Chennai #3
Sto faticando a fare foto.
Normalmente rischio l’effetto giapponese, qui invece ho un blocco. Scatto immagini, le riguardo e mi pare che non restituiscano nulla: non la sporcizia sedimentata in stratificazioni geologiche, non l’accozzaglia di oggetti, cemento, fiori freschi, fiori calpestati e incenso ai margini della strada, non le facce impastate di sudore, polvere e vita, non le mucche sdraiate in mezzo alla strada e centinaia di scooter, tuc tuc e auto incastrate intorno, non la gente buttata per terra a dormire e non – soprattutto – l’ordinarietà della scena, l’assoluta normalità, in cui l’unico vero elemento distonico sei tu con il tuo trolley colorato e gli occhiali da sole e i capelli biondi.
Dispacci, India – Goa #2
La classe media indiana esiste, e consuma smartphone e selfie stick (nonché, sospetto, soft porno in quantità).
Coi primi ci fa foto ovunque: si fa e ti fa. Hanno più foto di me in spiaggia gli indiani che tutta la mia famiglia, inclusi i parenti di secondo grando. Nel soft porno, infatti, alla fine ci sei dentro tu: cos’altro ci faranno mai con quei duecento selfie che ti hanno chiesto di fare in quanto strano soggetto esotico?

Dispacci, India – Goa #1
Dicono che a Goa ci vadano solo gli europei, qualche russo, un po’ di israeliani a mandare giù Mdma per dimenticarsi gli orrori della militarizzazione continua. Noi, però, ci abbiamo trovato praticamente solo indiani: quelli ricchi, turisti del weekend, che scappano dalle città e si intingono in questa giungla umida affacciata sul mare per bere birre e farsi selfie di coppia, etero e gay, senza divieti o timori. Di Mdma neppure l’ombra, ma non l’abbiamo cercato: che in giro ne esistano cascate è certo.
Dire Goa, comunque, non ha molto senso: il nome è quello dello Stato, una striscia lussureggiante e vagamente amazzonica. Sarà il passato coloniale portoghese, con le case colorate e le chiese maestose in mezzo alla foresta, ma a Panjim oggi mi pareva di essere tornata in Brasile. C’è pure un quartiere che si chiama Altinho, che un po’ sa di Pelurinho (Brasile) e un po’ di Trinidad (Cuba), ma col triplo degli insetti e l’acqua di scolo che si impasta con il terriccio, le foglie e la polvere formando un’argilla rossiccia che ti si attacca ai piedi e alle gambe a mo’ di henné permanente.
Poi c’è l’acqua quella dei monsoni, ogni qualche ora: il cielo passa dalla tonalità grigio chiaro pm10 a quella grigio scuro nubifragio in quattro minuti, un venticello si alza a illuderti con temporanee promesse di refrigerio e poi il cielo scarica 15, 20, 60 minuti d’acqua per cui non si scompone nessuno, e ormai nemmeno più noi.
Sui motorini gli indiani si compattano ancor più: quello che sta in mezzo – il numero medio per scooter è tre persone – tira fuori l’ombrello e copre sommariamente gli altri, quello che guida ripone il cellulare in tasca all’asciutto (normalmente ce l’ha in mano), il terzo si guarda intorno come se nulla fosse. Al termine dello scroscio il tasso di umidità passa dal consueto 80 al 160% e gli animali emergono dal sottosuolo; ieri un insetto non meglio identificato lungo circa 4 centimetri di colore marrone stava camminando lungo il petto di Cristina: l’ho cacciato sentendomi un’eroina e mentre mi chiedevo dove fosse finito l’ho visto scendermi giù da una coscia, con orrore pari solo a quello di quando salgo sulla bilancia il 27 dicembre.
Il monsone – per cui lo Stato spende in campagne educative del tipo: La stagione delle pioggia è qui, il traffico sarà un po’ più complicato del solito, quando esci di casa portati un libro – in ogni caso si è portato via i turisti sballoni, ma non la spiaggia. Oggi, dopo essere state a Old Goa, che fu una volta a capitale dell’impero indiano portoghese, grande quando Londra, con sette basiliche immense piantate nel mezzo di una vegetazione da Libro della Jungla (in effetti, Kipling era indiano), siamo partite alla volta del litorale Sud, costeggiando casette coloniali tutte colorate nascoste tra alberi e risaie.
Non pioveva, i bimbi indiani in mutande facevano il bagno nell’acqua ingrigita dal vento e dalla sabbia, i loro fratelli maggiori giocavano a calcio senza mai segnare un gol e al tramonto l’intero villaggio si era riversato sulla battigia, a prendere l’ultimo sole. Un’altra Goa è possibile.

Le foto di Obama, e quelle di Trump
Posted by gea in politica e dintorni on July 25, 2017
La settimana scorsa, a Cortona, sono incappata in una conferenza di Pete Souza, l’ex fotografo di Obama alla Casa Bianca. Non so dire se tecnicamente Souza sia un grande fotografo – stando ai parametri a volte perniciosetti per cui gli appartenenti a una categorie professionale parlano degli altri, specie se ancora vivi – ma so di certo che è stato eccezionale.
Magari non avete idea di chi sia ma avete comunque visto i suoi scatti, essendo stati sostanzialmente in mostra permanente sulla stampa intera per tutti gli anni della presidenza Obama: tra i meriti di Souza c’è quello di aver reso umano un mito e di aver mitizzato l’uomo.
Indice sommario: il presidente che gioca col bambino vestito da Spider Man, una corsa col cane Bo (e non chiedete perché Dudù non muove alla stessa tenerezza), un hamburger in maniche di camicia, una partitella a basket, oppure lui e Michelle in ascensore, a guardarsi negli occhi dopo una festa, o tutto lo staff nella situation room al momento dell’assassinio di Bin Laden eccetera eccetera.

È probabile che in questi anni le foto di Souza mi abbiano ammaliato anche per via dell’adorazione che ho per Obama (e no, non perché fosse un nero con una storia costruita ad arte. Trump almeno un merito ce l’ha: la differenza tra i due è così spaventosa che oggi nessuno può più dire che ci piaceva Obama solo perché era “diverso”). Mi sono chiesta più di una volta se mi stessi bevendo uno storytelling ben confezionato – che poi Filippo Sensi ha provato a imitare in modo un po’ grottesco con Renzi -, se stessi inconsapevolmente ripiegando tutto il mio spirito critico, se mi stessi ammalando ogni giorno di più di esterofilia e erbadelvicinismo, per così dire.
In parte; può essere. Non bisogna essere Asor Rosa per capire che, certo, nel portarci a un centimetro dalla faccia di Obama contratta dalla stanchezza Souza stava servendo un bon bon di benevolenza nella vita politica e nella capacità di giudicarla. Ci stava seducendo nemmeno troppo lentamente, scodellando l’immagine dell’uomo giusto e giudizievole, padre amorevole, marito appassionato, presidente sempre presente a se stesso senza perdere il lato giocoso, affabile, umano.
Non so voi, ma io di donne non innamorate di Obama non ne conosco. E di uomini politici di similsinistra che non abbiano provato a imitarlo, nei modi e nello stile, neppure.

In ogni caso mi ero quasi rassegnata a dimenticarmi dei momenti felici in cui la mattina aprivo i quotidiani e nel riquadro generalmente destinato a XFactor e alla ricetta del baccalà alla vicentina si trovavano gli ultimi scatti di Souza, quando l’ho sentito raccontare un aneddoto.
Stava mostrando una foto di Trump, preso di spalle, che entra nello Studio Ovale, probabilmente nei giorni del passaggio tra i due presidenti. Sullo sfondo un muro bianco occupato da un grande quadro.
«Ah, quel quadro non c’è più», ha buttato lì. «Quelli di Time hanno fatto un servizio di recente: hanno scattato dalla stessa posizione e ora su quella parete il dipinto è stato sostituito da una grande televisione».
In sala qualcuno ha riso, inclusa me: un desolato risetto carico di nostalgia.
A casa, invece, ho aperto Instagram e sono andata a guardare le cose che posta Trump (o qualcuno dei suoi), che generalmente scorro evitando di mettere a fuoco.
Tipo queste.



Sono, semplicemente, rozze. Grossolane, brutte nei colori, senza gusto se non quello di un celodurismo da America della Rust belt che scola lattine di birra sul retro di un pick up.
Stanno alla classe come gli strilli di copertina dei magazine degli Anni 80, alla sottigliezza di pensiero quanto Rovazzi o Bello Figo, all’eleganza quanto la visiera dritta al Borsalino.
E non è solo questione che l’elettore di Trump, quello cui lui si rivolge scompostamente davanti al maxischermo che fu quadro oggi sempre sintonizzato su Fox News, è sensibile solo (o particolarmente) a questi tipi di messaggi, essendo l’elettore stesso celodurista, incastrato negli anni 80, aspirazionalmente milionario ma senza un centesimo per andare al cinema.
No, nella scelta comunicativa di Trump c’è di più: c’è Trump.
Non è una scelta meditata: è lui che deborda. Lui, quello che ha sposato Ivana Trump e che delle donne racconta di afferrarle per i genitali (l’ho scritta bene: I grab them from the pussy suona un po’ diverso). Che ripete 30 parole da scuola media compulsivamente (nasty! sick! bad !good! nice! TUTTE MAIUSCOLE, ovviamente), che si addormenta davanti alla tivù con il telefono in mano e gli scappa di twittare Covfefe digitando a caso, perché non ha nemmeno l’autocontrollo necessario a capire quando sta per crollare e mettere giù lo smartphone. Che rifiuta di leggere documenti della Cia più lunghi di mezza facciata (meglio se glieli riassumono a voce) e articola il pensiero in 140 caratteri massimo.
Insomma, la comunicazione di Trump è lo specchio di Trump, e ne rappresenta meglio di qualsiasi analisi la superficialità.
Obama trasmetteva un’immagine, anche grazie agli scatti di Souza: semplice ma raffinata, popolare ma di classe, identitaria ma inclusiva. Trump entra nei social media con la bomba H, ogni post è un piccolo ordigno nucleare che annulla la possibilità di interrogarsi, di diventare curiosi, di coltivare la fantasia.
Un giro su Instagram, probabilmente, restituisce il personaggio Trump molto più di tutto quello che ne scriveranno i giornali e i biografi. Ha il pregio di togliere i dubbi: lo puoi quasi toccare, lo vedi grande, grosso e goffo, caricaturale in gesti sempre uguali, sempre un po’ troppo.
Il paragone con le immagini di Obama è così feroce da essere quasi intellettualmente insostenibile: pare di aver fatto un salto indietro di tre decenni, prima che instagram e le serie tivù riuscissero a livellare verso il medio anche i gusti dei senza speranza, per pura emulazione.
A breve – penso (spero) – uscirà una semiologia dell’immagine di Donald Trump. Purtroppo all’università non ho studiato abbastanza per scriverla io: sempre dopo ci si accorge di come si è sprecato il tempo.
[in compenso, con Gabri abbiamo creato questo: esercizi di controcultura mainstream]
Non solo bio
Posted by gea in gea and the city, il lavoro logora chi non ce l'ha on July 10, 2017
Lo ammetto: sono diventata sospettosa delle bio, non mi piacciono affatto.
Bio, e non biografie: la differenza esiste, nel linguaggio a cui siamo abituati. Le biografie sono scritti lunghi, tendenzialmente (auspicabilmente) di personaggi molto noti di cui scavano dettagli meno noti, quasi ineluttabilmente agiografie ma con un po’ di spazio per i bassi, prima o dopo gli alti.
Le bio sono la versione condensata, molto in voga sui social, sulle quarte di copertina, nelle presentazioni di festival, interventi, blog, giornali. Sono tendenzialmente agiografiche anche loro, e ancora non so se sia una specie di illusione ottica obbligata – la sinteticità comprime i bassi: restano solo gli altri – o una necessità di marketing di sé nell’epoca in cui anche la battute su Twitter devono essere capitalizzate. O forse un po’ di entrambe.
Quindi le bio non mi piacciono, anzi, m’affaticano proprio: m’irrigidisco quando leggo quelle degli altri e m’imbarazza scrivere la mia. Il che, peraltro, a lungo non mi ha impedito di declinare la tendenza agiografica, pur riconoscendola: fino a pochi istanti fa, prima che decidessi questo intervento, questo sito recitava così.
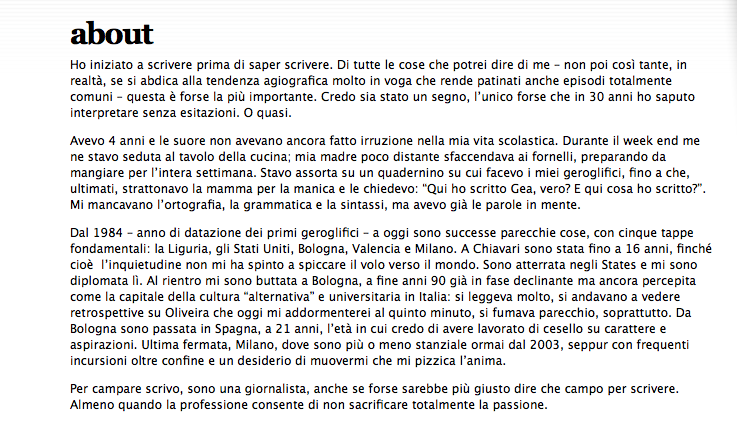
Non molto, in realtà, e soprattutto assolutamente vero, con quel punto di lirismo che aiuta il lettore a figurarsi una biondina con gli incisivi traballanti al tavolo della cucina. Ma tra quella bambina e la me stessa di oggi ci sono in mezzo indecisioni, insicurezze, dimissioni, lavori presi senza convinzioni, scritti probabilmente mediocri, decisioni rimandate e molto altro ancora.
Il problema delle bio è che comprimono tutto quanto. Prima di scrivere un libro, quanti ne avresti voluti iniziare senza riuscire? E dopo averne scritto uno? E prima di imbroccare una cosa giusta, quante ne hai sbagliate? Quante crisi hai avuto, quanti errori hai fatto?
Si dirà: è una bio, mica un saggio o un romanzo del sé. Non è che si debba personalizzare tutto, e troppo. Bisogna dire quello che funziona o ha funzionato: quello per cui qualcuno dovrebbe darti un lavoro o leggerti o comprarti.
Infatti il mio personale scetticismo nei confronti delle bio non riguarda l’onestà nei confronti dei potenziali lettori, quanto il mercato che – giocoforza – determinano.
Prendiamo l’editoria, che è in definitiva l’unica cosa che conosco abbastanza bene da poterne parlare. C’è chi scrive con la mano sinistra e la testa da un’altra parte pezzulli ripresi da comunicati su testate che magari pagano dopo un anno: ma le bio sembrano sempre quelle di novelli Montanelli richiestissimi. Ci sono praticanti che collaborano già con due o tre case editrici, e nella realtà magari scrivono blog non retribuiti. Ci sono quelli che vivono scrivendo comunicati stampa, e si firmano reporter. Mica è una colpa scrivere un blog non retribuito: però a furia di non dirlo potrebbe diventarlo, almeno indirettamente. Infatti il primo che dovesse scrivere la verità – sono giovane, questo mestiere è in crisi nera e il mercato asfittico e senza soldi e non mi paga nessuno – sembrerebbe subito uno sfigato, un perdente: com’è che tu hai una bio così noiosa?
Io, da tempo, ho iniziato a scrivere sui social Wish I could fit a bio, che è la cosa più onesta che posso dire rispetto al fatto che sono una giornalista ma faccio anche cose corporate, che nei giornali a tempo pieno ho scelto di non starci (scelto, sì: unico caso, o uno dei pochi, di assunta a tempo pieno con contratto regolare dimissionaria, rifiutante più di un altro posto del genere), che sono disposta a pagare una certa libertà facendo anche cose non sempre entusiasmanti.
Ma tutte queste riflessioni, ovviamente, non ci stanno in una bio.
Nel frattempo, insomma, ho deciso di espandere la mia ma anche di comprirmela (niente ghirigori e lirismo), in due lingue. Definiamolo un punto di partenza, finché non troverò un metodo migliore. Intanto, la trovate qui, con tanti saluti alla biondina al tavolo della cucina (eri bella, comunque, eh).
Millesimi
Posted by gea in gea and the city on June 29, 2017
Venticinque mila millesimi. Forse 2.500. O 200. Insomma, qualcosa così. Poi non importa che non abbia mai saputo cosa siano i millesimi e sia riuscita a comprare una casa e a viverci un anno senza impararlo: dannazione, andiamoci a prenderceli, ci servono, sono nostri, devono stare con noi.
Mi sentivo così, più o meno: la guerriera del millesimo. Mica per me, figuriamoci: non sapevo nemmeno come contarli, mai avrei potuto entrare in un’assemblea di condomino con una rivendicazione quale che sia. Ma c’era da combattere per la giusta causa di V., e le giuste cause io le prendo sul serio. Specie se la persona al fianco di cui schierarsi è la prova umana che quello che hai scritto, predicato e creduto per anni è vero.
Mi sono svegliata una mattina particolarmente nera, tre o quattro mesi fa, faticando a mettere i pensieri sufficientemente in fila per srotolare la giornata. Sotto casa, il mio motorino era di nuovo riverso al suolo, non dissimile dagli adolescenti sbronzi che la notte precedente lo avevano ridotto così. Non ho dovuto nemmeno chiamare il meccanico per sapere che con l’ultimo cambio di blocchetto sarei arrivata a cifra tonda: 1.000 euro di riparazioni in 12 mesi. Su uno scooter comprato usato 11 anni fa per 2 mila. Un po’ la sfiga: anche i migliori invecchiano. Molto la devastazione: sedicenni e dintorni pieni di cocktail in bicchieri da mezzo litro cappottati lungo Ticinese, in preda all’ebbrezza del vandalismo, e senza nemmeno la scusa della lotta al sistema.
Rassettando i pensieri e lo sconforto ho raccolto il motorino, sono rientrata dal portone e ho abdicato alla razionalità dell’estratto conto: Alì, mi dici se qualcuno nel palazzo affitta un posto auto? (Un posto auto, in questo quartiere, costa mensilmente quanto una casa intera a Genova: se mi chiamassero a parlare di gentrificazione, saprei da dove iniziare senza dover menzionare gli hipster).
Sono uscita con due numeri di telefono forniti dal portinaio: il primo apparteneva a un signore sguazzante nella gentrificazione; la seconda, V., in linea dalla Sardegna, ha ascoltato la mia richiesta con la pazienza dei giusti, ci ha ragionato un po’, poi mi ha risposto: Non so ancora se voglio affittarlo quel posto, fa parte di una storia famigliare, ma nel frattempo puoi usarlo gratis: io credo al buon vicinato.
Avrei voluto gridarle Grazie, sei un segno, ti ha mandato il karma, ti voglio benissimo e so che faccio bene a volertene prima ancora di averti visto, ma un guizzo di lucidità mi ha bloccato: magari all’altro capo del telefono avrebbe pensato che ero una povera squilibrata, e in quel momento avevo davvero bisogno che credesse alla mia affidabilità. Quindi ho ringraziato, spiegato sommariamente chi sono e cosa faccio e constatato con sollievo che talvolta la vita fa il giro: quello che dai in qualche modo ritorna.
Così, parecchie settimane dopo quella telefonata, mentre andavamo alla riunione di condominio, la prima a cui avessi mai partecipato, V. mi ha spiegato cosa sono i millesimi: unità di misura, il palazzo vale 1.000. Per cui ovviamente quelli che ci servivano non potevano essere ne 250 mila né 2.500, ma una ventina circa: abbastanza per dichiarare valida l’assemblea e discutere della sua richiesta.
Ci siamo sedute in prima fila – nemmeno alle elementari mi ero mai seduta in prima fila, nemmeno a sentire Civati moderato da Cirri, nemmeno al concerto di Vasco quando avevo 16 anni – ed è stato subito chiaro che non ce l’avevamo fatta: nei palazzi di Milano i lobbisti possono essere peggiori che alla commissione europea. Il numero legale mancava, inferiore ai 500 millesimi: battaglia rimanda a settembre. Troppi gli assenti, troppe le deleghe affidate e delegati poi risultati assenti, ri-cedute in pacchetti a delegati terzi che a quel punto però avevano orientamenti opposti a quelli degli incaricati: e se funziona così nel mio palazzo, figuriamoci in parlamento.
Così, col voto sospeso e la battaglia per la giusta causa di V. in stand by, non m’è rimasto che restare a osservare l’ animale sociale che è l’assemblea condominiale: un magma di gente che si coalizza e si insulta in geometrie variabili e fluttuanti, versione metropolitana del coro greco, di crescendi in polifonia e spigoli pungenti.
Dieci minuti a cercare un presidente.
Chi lo fa questa sera?
Signor T, lo faccia lei, su.
No, io no, l’ho fatto tutto l’anno scorso.
E lo rifaccia.
Ho detto di no, non ne ho voglia.
Ma su, cosa le costa, quest’anno non si è ancora nemmeno depilato le gambe!
Risate a fondo sala. Resistenza passiva del signor T. Condòmini che si nascondono dietro al programma, come durante le interrogazioni a sorpresa al liceo.
Basta, ora se non viene fuori nessuno tiriamo a sorte.
Rumore di una porta che si apre: il tizio del negozio al piano terra, in ritardo. Il signor T. si alza.
Piuttosto che sedermi vicino a questo, faccio il presidente.
Risate distensive: l’idea di fare il presidente aveva davvero terrorizzato parecchi.
Sei punti da discutere, più varie ed eventuali. Due saltano per assenza del numero legale di millesimi, due riguardano soldi da spendere.
Basta coi Mav. I mav costano. Abbiamo 2 mila euro di Mav inevasi, e perché dobbiamo pagarli, eh, perché? Ma siete pazzi, io non li pago i vostri Mav, pagateli voi.
No signora, guardi che la cifra non è quella, c’è gente che paga col bonifico, per quello che risultano inevasi.
Io non li pago, io non li pago i vostri Mav: è un’insensatezza.
Signora, non li sta pagando: è che qualcuno salda le rate cash, per quello risultano inevasi.
Appunto, io non li pago, ma perché li devo pagare io i vostri?
Signora non li sta pagando!
Appunto, e non voglio iniziare a farlo.
Signora, ne abbiamo discusso un’ora e mezzo l’anno scorso, ma che problema ha? Non li sta pagando, lo capisce o no?
E lei come se lo ricorda che ne abbiamo già parlato? Io non li pago i vostri Mav!
Signora, lei è pazza, ma cosa vuole, ma la smetta!
Io non li pago, ve lo dico.
Signora, ma vada a quel paese!
Sulle mie ginocchia languono dimenticati i compiti degli studenti che pensavo di correggere per ingannare il tempo prima del voto sulla richiesta di V.: mica potevo saperlo che fosse così divertente.
La pizzeria fa un odore terribile (a me, da quando m’hanno tolto il glutine, a dire il vero pare un profumino…)
Bisogna che tengano chiusa la porta.
Chi li conosce? Andateci a parlare.
Se posso pevmettervi, faccio l’avvocato a Londva. Pavlave non serve: svriviamo una letteva. Se non li denuncia il condominio, lo facciamo noi.
Dopo scriviamo la lettera, prima parliamoci.
Vipeto, c’è una violazione del codice: il nostvo inquilino lamenta un odove tevvibile.
Ma lei dove abita, scusi, in che palazzina?
Ah, quella dove c’è la signora col cane.
Vogliamo parlare dei cani? Questo palazzo è pieno: poi quelli li lasciano soli e questi abbaiano.
Io non li sento mai, a dire il vero. Nella mia scala ce ne sono tre: mi fanno abbastanza simpatia quando li vedo. Ma la lobby del cane deve essere potentissima: due cocker, un bastardino, poi quel cane lungo lungo, quello grigio, quell’altro là…
Ma il proprietario del lungo lungo quanti millesimi ha scusi?
Già e poi c’è l’annosa questione dell’appartamento del primo piano. Il proprietario è morto senza eredi: e ora chi le paga le spese del condominio arretrate?
Vero, come si fa a recuperarle?
Bisognerebbe vendere l’appartamento, ma non è a norma, non lo vuole nessuno, finirà all’asta.
Frenetica consultazione delle tabelle millesimi. Da parte mia: ora che ho imparato cosa sono, vado pazza per i millesimi.
Ma che problemi ha l’appartamento, che lo vuole nessuno?, sento dire dalla mia voce
Lasci stare, è un casino, la signora ha tirato giù tutti i muri, non le piacevano le pareti.
Ah, come me – è ancora la mia voce. Non è che si può vedere? Cioè, se non lo vuole nessuno, eh.
Io ho 11 millesimi. Se prendessi l’appartamento fantasma potrei arrivare sicuro a 23 almeno.
E se facessimo una festa in cortile? – sono ancora io.
Siamo seri su, l’avvocato non verrà mai. Non vorrà mai.
Ma facciamola, è carino.
Possiamo passare alle varie ed eventuali, per favore?
Ma la festa? Posso organizzare la festa?
Le varie ed eventuali, su, è mezzanotte.
La festa la prossima volta, ok. Magari nel frattempo avrò fatto un crowdfunding per l’appartamento fantasma. E col potere dei miei millesimi potrò organizzare un party.
Adesso ho infine capito a cosa servono.
I need a guru, I need some law
Posted by gea in gea and the city on June 14, 2017
Se esistesse un manifesto della mia vita, oggi sarebbe questo.
I need a guru, I need some law
Explain to me the things we saw
Why it always comes to this
It’s all downhill after the first kiss
Maybe I should move to Rotterdam
Maybe move to Amsterdam
I should move to Ireland, Italy, Spain
Afghanistan where there is no rain
Or maybe I should just learn a modern dance
Where roles are shifting the modern dance
You never touch you don’t know who you’re with
This week, this month, this time of year
This week, this month, this time of year
Doin’ a modern dance
Se ci sei, batti un colpo
Posted by gea in alla rinfusa on June 10, 2017
Al mondo deve esserci qualcun altro che gira su treno con un sacco pieno di scolapasta, mentre corregge Faq su basecamp con indosso occhiali grossi quanto piattini da caffè perché nell’ultimo mese ha dormito dieci ore in tutto.
Amico scoppiato, vieni fuori, dai: è ora di farmi sentire meno sola.
Certe notti
Posted by gea in alla rinfusa on May 31, 2017