Archive for category il lavoro logora chi non ce l’ha
Non solo bio
Posted by gea in gea and the city, il lavoro logora chi non ce l'ha on July 10, 2017
Lo ammetto: sono diventata sospettosa delle bio, non mi piacciono affatto.
Bio, e non biografie: la differenza esiste, nel linguaggio a cui siamo abituati. Le biografie sono scritti lunghi, tendenzialmente (auspicabilmente) di personaggi molto noti di cui scavano dettagli meno noti, quasi ineluttabilmente agiografie ma con un po’ di spazio per i bassi, prima o dopo gli alti.
Le bio sono la versione condensata, molto in voga sui social, sulle quarte di copertina, nelle presentazioni di festival, interventi, blog, giornali. Sono tendenzialmente agiografiche anche loro, e ancora non so se sia una specie di illusione ottica obbligata – la sinteticità comprime i bassi: restano solo gli altri – o una necessità di marketing di sé nell’epoca in cui anche la battute su Twitter devono essere capitalizzate. O forse un po’ di entrambe.
Quindi le bio non mi piacciono, anzi, m’affaticano proprio: m’irrigidisco quando leggo quelle degli altri e m’imbarazza scrivere la mia. Il che, peraltro, a lungo non mi ha impedito di declinare la tendenza agiografica, pur riconoscendola: fino a pochi istanti fa, prima che decidessi questo intervento, questo sito recitava così.
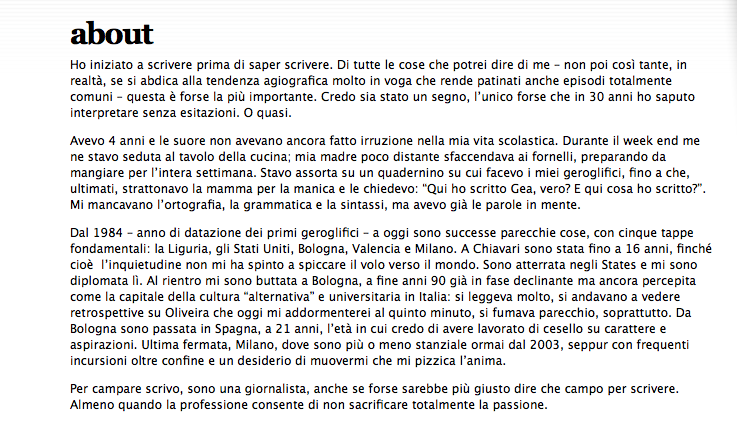
Non molto, in realtà, e soprattutto assolutamente vero, con quel punto di lirismo che aiuta il lettore a figurarsi una biondina con gli incisivi traballanti al tavolo della cucina. Ma tra quella bambina e la me stessa di oggi ci sono in mezzo indecisioni, insicurezze, dimissioni, lavori presi senza convinzioni, scritti probabilmente mediocri, decisioni rimandate e molto altro ancora.
Il problema delle bio è che comprimono tutto quanto. Prima di scrivere un libro, quanti ne avresti voluti iniziare senza riuscire? E dopo averne scritto uno? E prima di imbroccare una cosa giusta, quante ne hai sbagliate? Quante crisi hai avuto, quanti errori hai fatto?
Si dirà: è una bio, mica un saggio o un romanzo del sé. Non è che si debba personalizzare tutto, e troppo. Bisogna dire quello che funziona o ha funzionato: quello per cui qualcuno dovrebbe darti un lavoro o leggerti o comprarti.
Infatti il mio personale scetticismo nei confronti delle bio non riguarda l’onestà nei confronti dei potenziali lettori, quanto il mercato che – giocoforza – determinano.
Prendiamo l’editoria, che è in definitiva l’unica cosa che conosco abbastanza bene da poterne parlare. C’è chi scrive con la mano sinistra e la testa da un’altra parte pezzulli ripresi da comunicati su testate che magari pagano dopo un anno: ma le bio sembrano sempre quelle di novelli Montanelli richiestissimi. Ci sono praticanti che collaborano già con due o tre case editrici, e nella realtà magari scrivono blog non retribuiti. Ci sono quelli che vivono scrivendo comunicati stampa, e si firmano reporter. Mica è una colpa scrivere un blog non retribuito: però a furia di non dirlo potrebbe diventarlo, almeno indirettamente. Infatti il primo che dovesse scrivere la verità – sono giovane, questo mestiere è in crisi nera e il mercato asfittico e senza soldi e non mi paga nessuno – sembrerebbe subito uno sfigato, un perdente: com’è che tu hai una bio così noiosa?
Io, da tempo, ho iniziato a scrivere sui social Wish I could fit a bio, che è la cosa più onesta che posso dire rispetto al fatto che sono una giornalista ma faccio anche cose corporate, che nei giornali a tempo pieno ho scelto di non starci (scelto, sì: unico caso, o uno dei pochi, di assunta a tempo pieno con contratto regolare dimissionaria, rifiutante più di un altro posto del genere), che sono disposta a pagare una certa libertà facendo anche cose non sempre entusiasmanti.
Ma tutte queste riflessioni, ovviamente, non ci stanno in una bio.
Nel frattempo, insomma, ho deciso di espandere la mia ma anche di comprirmela (niente ghirigori e lirismo), in due lingue. Definiamolo un punto di partenza, finché non troverò un metodo migliore. Intanto, la trovate qui, con tanti saluti alla biondina al tavolo della cucina (eri bella, comunque, eh).
Questa notte è per voi
Posted by gea in giornali e dintorni, il lavoro logora chi non ce l'ha, libri on May 25, 2017
Domani, finalmente, apriamo le iscrizioni a FreeJourn. Domani, in questo momento della serata, appare ancora discretamente lontano: mi candido a infilare la seconda notte di fila davanti al computer, dopo il secondo giorno incollata al telefono, a basecamp, a documenti da ricostruire, tradurre, emendare.
Pensavo che avrei avuto un cedimento invece, finora, è stato divertente: intenso, stressante, consumante, ma divertente. Ho trascorso gli ultimi giorni con il mac su un tavolino in terrazza, il sole a squagliarmi di giorno e i moscerini a ronzare la sera, parecchie birre e pizze surgelate, Giuliana e Niccolo a guardare le immagini, video da 10 giga da scaricare e foto da scoprire, molti spaventi, qualche insoddisfazione, la paura di non farcela.
Potrebbe succedere: FreeJourn* è una bella idea che potrebbe andare benissimo ma anche fallire miseramente, perché i soldi, la partecipazione e l’editoria sono al momento tre variabili di un’equazione insoluta. Lo sapevo anche quando ho iniziato a lavorarci sopra e coi mesi mi è stato sempre più chiaro: oggi ne sono consapevole col disincanto di chi ha cresciuto quasi un figlio, ma poi deve accettare che a scuola conosca una gang di teppisti e se ne lasci affascinare. Forse, d’altronde, me ne farei affascinare anche io.
In fin dei conti non conta poi molto. L’importante è quello che ha dato, e cioè il processo della creazione: sembra una frase da TedX di provincia, ma non sempre si è abbastanza bravi con le parole per condensare adeguatamente la carica emozionale che vorresti metterci dentro.
Ho smesso di credere nel giornalismo da parecchio. Forse quando lasciai la guida di Lettera43, forse molto prima. Già: esiste qualcosa di peggio di una giornalista che dice qualcosa del genere? Magari mi radieranno dall’ordine, magari mi taglieranno le collaborazioni: sarebbe una bella prova di certe dinamiche e cointeressenze, quindi non credo che succederà. D’altronde non è che non creda al giornalismo come istituzione: figuriamoci, penso di essere una dei cento in Italia a pagare ancora una serie di abbonamenti a riviste anglosassoni. E non è nemmeno che per fare i giornalisti si debba stare per forza in un Paese anglofono – anche se, detto onestamente, credo che aiuti parecchio.
Quello che mi ha stancato è la pratica del giornalismo. Le redazioni chiuse in loro stesse, forzate alla scrivania dal conto economico, costrette al realismo, ai social network, all’innovazione, alle agenzie, all’essere sempre più brillanti, in spazi sempre più stretti («Due scroll! Tre al massimo: ragazzi, nessuno va oltre il terzo scroll, non dobbiamo fargli fare fatica!»), a trasformare qualsiasi tendenza giovanilistica in discorso sociologico, coi capiredattori a fare da risorse umane e i redattori a fare tutto il resto. Certo, non è detto che sia sempre così, eppure di redazioni ne ho frequentate abbastanza per sapere che è un male diffuso.
Forse è colpa – merito? – di chi mi ha avvicinato al mestiere, forse dei libri che ho letto e di certe idee di ragazzina che a 37 anni ha scoperto di avere un’allergia alle gerarchie e alle sclerotizzazioni che comportano. Ma quello che cerco nelle cose che leggo è una dimensione più intensa, dilatata, anche creativa: sono sempre stata una da racconto lungo, molto prima che long form diventasse una parola di moda. Le cose che mi piacciono non ci stanno in due pagine e spesso nemmeno in sette, di solito oggi diventano video che guardi in cinque minuti senza la fatica di dovertele immaginare mettendo insieme gli elementi. A me piacciono soprattutto quando sono libri, tipo i David Foster Wallace e gli Hunter S. Thompson e i Lester Bangs, che ovviamente non sono esempi facili ma anche oggi c’è chi ha le idee e sa come realizzare, e mi vengono in mente i River Boom, tra molti (sì, sono anche miei amici, il che peraltro mi fa ancora più contenta nel dire che siano geniali).
Forse sono all’antica, di un tempo e di un modo che nella pratica del giornalismo non esistono più e non hanno più nemmeno ragione di esistere: il reportage, le venti pagine di intervista, l’inchiesta che non devi memorizzare 60 nomi in 30 righe, ma in cui li conosci pian piano, entri dentro alla loro vita e alle loro pratiche.
Forse invece banalmente in me la parte giornalistica in senso ortodosso, che a molti dà grandi soddisfazioni e che qualcuno fa molto bene, si è diluita in una cosa più autoriale, che con le notizie si sovrappone solo in minima parte: e so bene che le notizie sono l’essenza del giornalismo (poi, ovviamente, bisognerebbe intendersi sul concetto di notizia e anche di come si informano le persone, ma questo comporterebbe aprire un altro discorso ancora).
Tutto questo per dire che FreeJourn, pur con qualche limite e gli errori che certamente abbiamo fatto e che faremo ancora, pur col rischio che domani al sign up non tengano i server o chissà che, è stato anche un modo bello di ritrovare l’entusiasmo: dopo Mi fido di te e prima di Godstock (teaser: se davvero andasse bene, Gabri e io ci metteremo un paio di anni a scodellarvelo, temo), trasversale ai miei interessi e alle opportunità. Ci ha lavorato un gruppetto di persone assortito, e tutte hanno dato un contributo essenziale; c’ho trovato dentro il piacere di una squadra fortissimi, un’amica, l’abbattimento di certi pregiudizi, il piacere di chi ha voglia di buttarsi in qualcosa, l’importanza dell’equilibrio.
Questa notte, insomma, va così.
E se siete giornalisti freelance, buonanotte, questa notte è per voi.
[* FreeJourn è una piattaforma per reporter freelance, essenzialmente, ma se lo volete scoprire con calma ci sono il blog, i social e fra pochissimo anche i moduli online per iscriversi].

La potenza distruttiva dell’equo compenso
Posted by gea in gea and the city, giornali e dintorni, il lavoro logora chi non ce l'ha on November 12, 2014
Ho avuto un’epifania: non so più scrivere.
Non è un granché come scoperta, specie in questo momento. Ma facciamo che non lo dite al mio editore e auspicabilmente lui potrebbe non accorgersene.
E’ andata così: ho passato talmente tanto tempo negli ultimi mesi (anni?) a leggere in inglese che non so più scrivere in italiano. Quindi mi autodenuncio. In parte anche per salvare i 20 milioni di bambini e adolescenti le cui madri, in questo momento, staranno gracchiando o supplicando compassionevoli: «Marco (o: Cosimo, Antonietta, Genoveffa, Giulia, Stefano), perché non leggi un po’ in inglese? Ti farebbe così bene. Lo dice anche la tua insegnante che ne avresti bisogno per impararlo meglio: non rincretinerti davanti ai videogame, leggi in inglese».
(Ai Marco o Cosimo, Antonietta, Genoveffa, Giulia, Stefano: vostra madre, comunque, ha ragione).
Insomma, un problema c’è. Gli anglosassoni, specie i giornalisti, sono lineari. Elementari. Diretti. Soggetto, verbo, complemento. Ogni frase* fa procedere il discorso: non ci gira mai intorno. Non so se la differenza è chiara, ma dovrebbe esserla: gli italiani sublimano i discorsi con una scrittura piena di rimandi, giochi, allusioni, espressioni un po’ retrò che fanno scena, citazioni dotte e via discorrendo. Poi magari qualche lettore non ci capisce nulla, ma certamente è colpa sua: non è abbastanza intelligente o preparato.
Gli anglosassoni no, sono spicci. Anche quelli che vincono il Pulitzer. Contate il numero di ripetizioni in un’inchiesta qualsiasi del New York Times (vanno bene tutte: sono tutte eccellenti) e saprete quante mazzate avreste preso dal vostro caporedattore se foste stati voi a scriverlo così, quel pezzo lì.
E’ successo che, siccome i quotidiani italiani dedicano 13 pagine al giorno a presunti retroscena che spesso sono poco più di congetture sulla base dell’umore, due a notizie di Ansa commentate e rincicciate e un paio magari a cose buone, spesso ispirate (quantomeno) dai giornali stranieri, io da anni leggo con attenzione soprattutto i giornali stranieri. E no, se dicessi che scrivo come il Nytimes meriterei comunque una bella serie di mazzate: perché magari esserne capaci davvero.
Invece sono in quella fase in cui i ghirigori mi risultano indigeribili, figli di un Ego maggiore che deborda in pagina, ma l’asciuttezza americana diventa stringatezza. E poi quell’asciuttezza lì va bene se hai in mano lo scoop delle armi chimiche in Iraq, altrimenti diventi arido come un dolce non lievitato.
Se poi volessimo proseguire, dovremmo aggiungere che lo scoop delle armi chimiche in Iraq ce lo hai in mano se l’editore è disposto a spendere più di 20 euro a pezzo: ma da noi, il sindacato nazionale giornalisti e l’associazione degli editori hanno ritenuto che quello sia un equo compenso.
Il che riporta all’esigenza di leggere altro, perché quotidiani che pagano redattori (spesso) incartapecoriti, maratoneti del retroscena fino all’ultimo respiro, corrispondenti dall’estero che riassumono (a volte anche brillantemente) i pezzi di altri e poveri freelance che se dimostrano di aver bisogno di soldi vengono tacitamente umiliati producono davvero poco di stimolante (eccezione fatta per i freelance, spesso).
Ma più leggi in inglese più scrivi come se fossi inglese, però in italiano: e questo è un problema.
In fin dei conti, dunque, se non so più scrivere è colpa dell’equo compenso, anche se al momento non mi pagano nemmeno. Pensa che potenza distruttiva.
*una versione precedente di questo articolo recitava: “Ogni sentenza fa procedere il discorso”, al posto di “ogni frase”. Dall’inglese: sentence. La prova che sono fritta.
**il pezzo sui freelance linkato poco sopra è quello di Michele Masneri uscito sul Foglio: una lettura antologica.
E beccatevi il concorsone
Posted by gea in il lavoro logora chi non ce l'ha on December 3, 2012
Insider trading, da geolina a lettera43.
Samuele Fiumi ci racconta in anticipo il concorsone.