Archive for category gea and the city
Ho un debito con la primavera | Spring and I
Posted by gea in gea and the city on March 31, 2020
Ho un debito con la primavera, o forse è lei che vuole qualcosa da me.
Abbiamo un rapporto intimo, carnale, quasi ossessivo: speranza, appartenenza, rifiuto. Come due ex amanti.
Questa è la seconda primavera che passo in isolamento: oggi è il coronavirus; l’anno scorso un incidente.
Ero sotto a un respiratore, l’anno scorso, uno di quelli che ti salvano la vita quando i tuoi polmoni non funzionano più, quelli che oggi scarseggiano e vengono rimpiazzati dalla maschere da snorkeling di Decathlon grazie al genio di un gruppo di ingegneri.
Lo so come si sta sotto a quel casco, me lo ricordo bene. Me lo ricordo anche se stavo prendendo svariati grammi di morfina al giorno e un cocktail di altri farmaci sufficienti a stendere un cavallo. C’è caldo e c’è un rumore infernale, lì sotto. E pesa, il casco, è difficile indossarlo, specie se hai tutte le ossa del corpo rotte come ce le avevo io l’anno scorso. E devi essere bravo, non lasciare mai che la paura che hai da qualche parte, addormentata dai sedativi, si svegli e ti chieda che diavolo ci fai con una cosa da astronauta in testa, che ti immobilizza, che ti spara aria addosso, da cui sai di non poterti liberare.
L’anno scorso mi hanno liberato il 25 aprile. Mi hanno mandato a casa e con mio fratello abbiamo sorriso della mia nuova festa della liberazione. Poi i sorrisi sono finiti, perché è iniziato il lungo periodo in cui non ero più in ospedale ma ancora non stavo bene, e vedevo scorrere i giorni e le settimane, sentivo la primavera palpitare fuori dal vetro della cameretta in cui stavo rinchiusa, e sapevo di non poterla vivere.
Ci ho messo un paio di mesi l’anno scorso, a rimettermi in piedi. E quasi quattro per stare decentemente: 18 costole e una clavicola rotta, due polmoni collassati, un orecchio riattaccato e punti ovunque ti segnano a lungo.
Avevo messo in programma una festa, in questi giorni, per celebrare l’anniversario dell’incidente, la vita che mi sono tenuta stretta, l’amore degli amici che mi ha curato più dei farmaci.
Il coronavirus la impedirà: ci sta tenendo in casa, confinati, in rapporti scarnificati e al contempo sovrabbondanti, inondati di chat e dirette instagram, di paure nuove e di congetture su come sarà il mondo prossimo futuro.
Compivo 40 anni il 23 febbraio, il giorno in cui l’emergenza è scoppiata e si è deciso che avrebbero chiuso Milano. È passato un mese e una settimana, è arrivata la primavera, la sento che profuma sul balcone e corteggia le piante: si sta svegliando la mia gerbera, che precisa come un orologio a cucù ogni inverno se ne va in letargo ma ogni marzo, a dispetto del gelo dell’inverno e delle mie cure non sempre sufficienti, si stropiccia un po’ per poi alzarsi eretta e splendente.
È arrivata un’altra primavera e non la vedrò: questa volta saremo in tanti a non vederla. Quando ci libereranno, forse, sarà quasi estate.
E io penso che ho un conto sospeso con la primavera, con la gioia che mi dà attenderla, viverla, lasciare che mi entri dentro e mi scuota, risvegli i miei sensi e scacci via la pigrizia; ho un conto in sospeso con il desiderio di musica e parchi e di primo sole, con le birrette bevute in terrazzo quando le giornate si allungano nella sera, e la luce oscura il telegiornale e il rito dei televisori che si accendono all’unisono.
Ho un conto sospeso con la primavera, ma va bene così. Mi piace anche sapere che abbiamo una relazione speciale, noi due.
I owe to the Spring, or maybe she wants something from me.
We have an intimate, carnal, almost obsessive relationship: hope, belonging, rejection. Like two former lovers.
This is the second spring I spend in isolation: today is the coronavirus; last year it was an accident.
I was under a respirator last year, one of those helmets that save your life when your lungs don’t work anymore, those so scarce today, so hard to find that they were partially replaced by Decathlon snorkeling-masks, thanks to the genius of a group of engineers.
I know how it feels to be under that helmet, I remember it well. I remember it even though back then I was taking several grams of morphine a day and a cocktail of other drugs strong enough to knock out a horse. It’s hot and it’s noisy as hell down there. And the helmet is heavy, it’s hard to sustain, especially with every bone in your body broken like mine last year. And you have to be good, you never can let the fear that you buried somewhere, thanks to the sedatives, wake up and ask you what the hell you’re doing with an astronaut thing on your head that immobilizes you, that shoots air at you, that you know you can’t get rid of.
Last year I was released on April 25th. They sent me home and my brother and I smiled at my new liberation day. Then the smiles ended, because we entered the days when I was no longer in the hospital but I was still very ill, and I could see the days and weeks go by, I could feel the spring beating outside the glass of the bedroom where I was locked up, and I knew I couldn’t live it.
It took me a couple of months last year to get back on my feet. And almost four to recover almost entirely: 18 ribs and a broken collarbone, two collapsed lungs, one ear cut off and stitches everywhere leave their mark.
I had planned a party to celebrate the anniversary of the accident, the life I’ve been holding on to, the love of friends who treated me more than drugs.
The coronavirus will prevent it: it’s keeping us at home, confined, in bare and at the same time superabundant relationships, flooded with chat and direct instagram, with new fears and conjectures about what the world will be like in the near future.
I turned 40 on February 23, the day the emergency broke out and it was decided to quarantine Milan and Lombardy. A month and a week has passed, spring has arrived, I can feel it perfuming on the balcony and courting the plants. My gerbera is waking up: precise as a cuckoo clock, every winter she goes into hibernation, but every March, in spite of the winter frost and my feeble carecare, it crumples a little and then gets up erect and shining.
Another spring has come and I won’t see it: this time there will be many of us who won’t see it. And when we’ll finally regain something similar to freedom – – but just similar – perhaps, it will be almost summer.
And I think that I have an unfinished business with spring, with the joy I feel waiting for it, with its ability to pervade and shake me, to awaken my senses and drive away my laziness. I have an unfinished business with the desire for music and parks and the first sun, with the beers on the terrace when the days get longer in the evening, and the light obscures the news and the rite of the televisions turning on.
I have a score to settle with spring, but that’s okay. I also like knowing that we have a special relationship, the two of us.
Quarant’anni
Posted by gea in Dialoghi davanti al microonde, gea and the city on February 28, 2020
Certe mattine di pensieri inutili da coltivare, che scaldano un istante e poi lasciano esposti agli sbalzi climatici.
E la bellezza di avere l’età per scrollarli via semplicemente scuotendo la testa, senza perdere il piacere di averli fatti.
Risvegli
Posted by gea in gea and the city on February 9, 2020
Poi stamattina mi sono svegliata col magone, e infreddolita, anche se in questa stanza austriaca ci sono ventisei gradi costanti. Ho preso l’iPad per mettere su un classico dei risvegli col magone, Nothing compares to you, invece all’ultimo ho fatto partire Me ne frego di Achille Lauro. Ho ridacchiato per la scelta, mentre mi passava il magone.
(Ma Sinead O’Connor poi l’ho ascoltata lo stesso)
Che cos’è l’amor
Posted by gea in gea and the city on August 24, 2019
Le stories, invecchiare, il marketing
Posted by gea in Economia, gea and the city on July 18, 2019
Cose che odio al mondo
Posted by gea in gea and the city on June 7, 2018
1. Il ritardo
2. Gli aeroporti senza il finger
3. Gente che non si lava abbastanza
(Chiamatelo un post promemoria, da aggiornarsi con una certa costanza)
La nuova droga di New York
Posted by gea in gea and the city on October 15, 2017
In questi giorni a New York sono diventata una tossica di Whole Foods.
Whole Foods è una catena di supermercati biologici – e anche vegetariani, vegani, integrali, chilometro zero e tutti questi aggettivi positivi con cui si può connotare il cibo, e non solo – che qualche mese fa è stata comprata da Amazon per una cifra astronomica, 13 miliardi e rotti di euro. Ne ho scritto recentemente su Pagina99, un articolo che una come me dovrebbe leggere e poi farsi qualche domanda – su se stessa, innanzitutto: ma fare i giornalisti ed essere coerenti mica devono sempre per forza coincidere.
La prima volta che ho passato mezz’ora in un Whole Foods, comunque, è stato proprio per lavoro: ero andata a cercare dei biscotti senza glutine e mi sono bloccata davanti a un muro a cinque ripiani di latte senza lattosio: ce n’erano 59 varietà. Tra l’attonito e lo sgomento ho proseguito e mi sono messa a contare i cereali, poi gli aceti, gli sciroppi e cosi via, con il sospetto che valesse la pena di pensarci su.
Quando sono uscita, ero combattuta tra la fascinazione e il rigetto, entrambi fasciati nella tendenza a ridicolizzare per comprendere: esattamente in cosa saranno diverse le 59 bevande senza lattosio che tanto si sa – io lo so: io le compro, io sono allergica al lattosio – sono unicamente dei surrogati di normalità per chi non vuole o non può caricarsi le calorie del latte intero?
Nei giorni seguenti lo scetticismo non mi ha abbandonato, ma il richiamo delle 59 varietà ha iniziato ad agire con prepotenza su di me: qualsiasi cosa mi servisse, andavo a prenderla nell’immenso WholeFood dietro a casa. Finché ho sostanzialmente smesso di aver bisogno di scuse per passarci delle discrete mezz’ore: una sera ero invitata al ristorante da amici e mentre camminavo lungo la 54Esima quasi ne ero dispiaciuta, pensando al tabuleh libanese che avevo addocchiato la mattina.
Da WholeFood, infatti, puoi prendere la tua scatola di cartone rigorosamente riciclato e riempirla di quello che vuoi: ci sono vasche di broccoli perfettamente verdi e regolari, pomodorini, carciofi tagliati in spicchi perfetti, carote arancioni da mettere il buon umore, spinacini, insalate di tutti i tipi lavate e illuminate da qualche residua gocciolina, come se fosse rugiada e ci trovassimo in un campo dell’Idaho e non nella giungla urbana di Manhattan. Ci sono venti varietà di olive e un Soup Bar in cui scegliere tra sette o otto zuppe del giorno. C’è l’angolo sushi, dove due asiatici preparano al momento: ti puoi sedere e ordinare o prendere una delle vaschette appena fatte, che vanno esaurite ogni mezz’ora, non distante da giganteschi banchi di pesce in cui trionfano granchi da tre chili e il salmone selvatico dell’Alaska. C’è la gastronomia italiana, in cui si trovano i friarielli e il brasato, e quello mediorientale, con l’hummus, il babaganoush e il tabuleh.
Da Whole Foods c’è tutto, ed è tutto bello, buono, ben esposto. Secchi pieni di fiori freschi e piante di orchidee in vaso ti accolgono all’ingresso, alla discesa delle scale mobili che separano il magico mondo organic dal resto del centro commerciale; la colonna musicale è sempre ricercata – Talking Heads, Beck, Patti Smith – e a qualsiasi ora del giorno e della notte ci trovi centinaia di persone che girano per gli scompartimenti e controllano provenienze e prezzi in sneakers e tuta, e pur sotto ai neon e con carrelli strapieni fanno tutta un’altra impressione rispetto alla volgarità di quelli che due piani sopra inseguono con la stessa determinazione scarpe di Jimmi Choo o cereali in scatola.
Perché da Whole Foods ci vanno quelli che alla cassa prima di pagare prendono al volo una copia del New Yorker e magari anche una tesserina da 50 dollari per la beneficenza: come le ricariche telefoniche o quelle per l’Apple store, solo che il valore viene devoluto a una qualche Ong, e tu che hai fatto la spesa da Whole Foods rispettando l’ambiente e la natura e la salute, forgiando la tua levatura morale con l’acquisto consapevole, puoi anche essere buono con un solo gesto alla cassa, senza sforzi, perché la praticità è la prima qualità dell’uomo moderno. E il sistema, quando non ti può combattere, ti accomoda: vince sempre lui, ma l’importante è che tu non lo percepisca.
Le mie serate a New York
Posted by gea in gea and the city on October 10, 2017
Poi c’è chi dice chissà cosa fai a New York la sera, i rooftop, le luci, tutta quella gente.
Per esempio quel signore pelato, quello della foto qui sotto, che l’altra sera era il solo in sala con me quando sono arrivata al Lincoln Plaza, sulla Broadway in alto in alto, dove praticamente non è piu la Broadway che quasi tutti hanno in mente.
Erano le 19, avevo passato tutto il pomeriggio in biblioteca per scrivere un pezzo da mandare via e m’è venuta voglia di un filmetto. Ho scelto una sala vicino a casa e, proprio come a Milano, il cinema piu vicino è una specie di adorabile residuato bellico: c’è ancora un tizio che ti vende i biglietti e si scendono le scale per arrivare in questo spazio mai rinnovato dagli Anni 70, con le pareti decorate da poster un po’ sbiaditi di film culto e signori annoiati, appoggiati alle colonne, che controllano i biglietti parlottando tra loro.
Avevo scelto una proiezione ma poi, all’ultimo, ho cambiato idea: e quando è iniziato il film – nel frattempo in sala erano arrivate alla spicciolata qualche coppia e un paio di signore da sole, borghesia dell’Upper West, che legge il giornale aspettando che si abbassino le luci – ho scoperto che era un film francese in lingua originale, sottotitolato in inglese. E tutti ridevano, perché era buffo, e a quelli dell’Upper West pensare a Godard e a Agnes Varda ricorda gli anni della loro libertà, e io ridevo di loro che ridevano e ridevo anche di me lì in mezzo a quella scena woodyalleniana; ma contemporaneamente mi sentivo proprio a casa mia, un po’ perché in America mi sento sempre a casa e un po’ perché io sono proprio quel tipo lì, che a NYC va a vedere un film francese in una sala microscopica lontano dal casino.
Oppure quello – sempre per il capitolo le tue serate a New York – che si iscrive a un corso serale di yoga allo YMCA, un corso il cui maestro è uscito diretto da Harry ti presento Sally, ma la prima parte, quella della fine Anni 70, o magari dai Tenembaum. Un tipo con il fisico un po’ da lattina, piccolo ma molto sodo e molto muscoloso, con dei calzoncini di cotone corti evidentemente senza mutande e una zazzera di capelli che nemmeno Bob Dylan all’epoca. Eravamo in palestra lui e io, un signore obeso che sudava anche solo a muovere le dita – Very good John, very good, just a little more -, uno che respirava con la stessa intensità sonora della Quinta strada, una settantenne ultra tonica che cercava di richiamare l’attenzione dell’istruttore, una ragazza di colore incredibilmente più impedita di me e un’indiana che a metà ha abbandonato il corso, poco prima che ci facesse mettere le gambe dietro la schiena e che io rischiassi di non alzarmi mai più da quella posizione.
Così passo le mie serate a New York, insomma. E come si sta bene.

Non solo bio
Posted by gea in gea and the city, il lavoro logora chi non ce l'ha on July 10, 2017
Lo ammetto: sono diventata sospettosa delle bio, non mi piacciono affatto.
Bio, e non biografie: la differenza esiste, nel linguaggio a cui siamo abituati. Le biografie sono scritti lunghi, tendenzialmente (auspicabilmente) di personaggi molto noti di cui scavano dettagli meno noti, quasi ineluttabilmente agiografie ma con un po’ di spazio per i bassi, prima o dopo gli alti.
Le bio sono la versione condensata, molto in voga sui social, sulle quarte di copertina, nelle presentazioni di festival, interventi, blog, giornali. Sono tendenzialmente agiografiche anche loro, e ancora non so se sia una specie di illusione ottica obbligata – la sinteticità comprime i bassi: restano solo gli altri – o una necessità di marketing di sé nell’epoca in cui anche la battute su Twitter devono essere capitalizzate. O forse un po’ di entrambe.
Quindi le bio non mi piacciono, anzi, m’affaticano proprio: m’irrigidisco quando leggo quelle degli altri e m’imbarazza scrivere la mia. Il che, peraltro, a lungo non mi ha impedito di declinare la tendenza agiografica, pur riconoscendola: fino a pochi istanti fa, prima che decidessi questo intervento, questo sito recitava così.
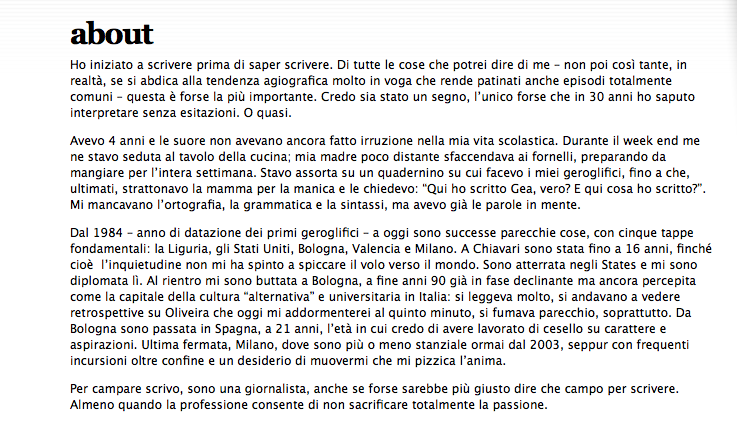
Non molto, in realtà, e soprattutto assolutamente vero, con quel punto di lirismo che aiuta il lettore a figurarsi una biondina con gli incisivi traballanti al tavolo della cucina. Ma tra quella bambina e la me stessa di oggi ci sono in mezzo indecisioni, insicurezze, dimissioni, lavori presi senza convinzioni, scritti probabilmente mediocri, decisioni rimandate e molto altro ancora.
Il problema delle bio è che comprimono tutto quanto. Prima di scrivere un libro, quanti ne avresti voluti iniziare senza riuscire? E dopo averne scritto uno? E prima di imbroccare una cosa giusta, quante ne hai sbagliate? Quante crisi hai avuto, quanti errori hai fatto?
Si dirà: è una bio, mica un saggio o un romanzo del sé. Non è che si debba personalizzare tutto, e troppo. Bisogna dire quello che funziona o ha funzionato: quello per cui qualcuno dovrebbe darti un lavoro o leggerti o comprarti.
Infatti il mio personale scetticismo nei confronti delle bio non riguarda l’onestà nei confronti dei potenziali lettori, quanto il mercato che – giocoforza – determinano.
Prendiamo l’editoria, che è in definitiva l’unica cosa che conosco abbastanza bene da poterne parlare. C’è chi scrive con la mano sinistra e la testa da un’altra parte pezzulli ripresi da comunicati su testate che magari pagano dopo un anno: ma le bio sembrano sempre quelle di novelli Montanelli richiestissimi. Ci sono praticanti che collaborano già con due o tre case editrici, e nella realtà magari scrivono blog non retribuiti. Ci sono quelli che vivono scrivendo comunicati stampa, e si firmano reporter. Mica è una colpa scrivere un blog non retribuito: però a furia di non dirlo potrebbe diventarlo, almeno indirettamente. Infatti il primo che dovesse scrivere la verità – sono giovane, questo mestiere è in crisi nera e il mercato asfittico e senza soldi e non mi paga nessuno – sembrerebbe subito uno sfigato, un perdente: com’è che tu hai una bio così noiosa?
Io, da tempo, ho iniziato a scrivere sui social Wish I could fit a bio, che è la cosa più onesta che posso dire rispetto al fatto che sono una giornalista ma faccio anche cose corporate, che nei giornali a tempo pieno ho scelto di non starci (scelto, sì: unico caso, o uno dei pochi, di assunta a tempo pieno con contratto regolare dimissionaria, rifiutante più di un altro posto del genere), che sono disposta a pagare una certa libertà facendo anche cose non sempre entusiasmanti.
Ma tutte queste riflessioni, ovviamente, non ci stanno in una bio.
Nel frattempo, insomma, ho deciso di espandere la mia ma anche di comprirmela (niente ghirigori e lirismo), in due lingue. Definiamolo un punto di partenza, finché non troverò un metodo migliore. Intanto, la trovate qui, con tanti saluti alla biondina al tavolo della cucina (eri bella, comunque, eh).
Millesimi
Posted by gea in gea and the city on June 29, 2017
Venticinque mila millesimi. Forse 2.500. O 200. Insomma, qualcosa così. Poi non importa che non abbia mai saputo cosa siano i millesimi e sia riuscita a comprare una casa e a viverci un anno senza impararlo: dannazione, andiamoci a prenderceli, ci servono, sono nostri, devono stare con noi.
Mi sentivo così, più o meno: la guerriera del millesimo. Mica per me, figuriamoci: non sapevo nemmeno come contarli, mai avrei potuto entrare in un’assemblea di condomino con una rivendicazione quale che sia. Ma c’era da combattere per la giusta causa di V., e le giuste cause io le prendo sul serio. Specie se la persona al fianco di cui schierarsi è la prova umana che quello che hai scritto, predicato e creduto per anni è vero.
Mi sono svegliata una mattina particolarmente nera, tre o quattro mesi fa, faticando a mettere i pensieri sufficientemente in fila per srotolare la giornata. Sotto casa, il mio motorino era di nuovo riverso al suolo, non dissimile dagli adolescenti sbronzi che la notte precedente lo avevano ridotto così. Non ho dovuto nemmeno chiamare il meccanico per sapere che con l’ultimo cambio di blocchetto sarei arrivata a cifra tonda: 1.000 euro di riparazioni in 12 mesi. Su uno scooter comprato usato 11 anni fa per 2 mila. Un po’ la sfiga: anche i migliori invecchiano. Molto la devastazione: sedicenni e dintorni pieni di cocktail in bicchieri da mezzo litro cappottati lungo Ticinese, in preda all’ebbrezza del vandalismo, e senza nemmeno la scusa della lotta al sistema.
Rassettando i pensieri e lo sconforto ho raccolto il motorino, sono rientrata dal portone e ho abdicato alla razionalità dell’estratto conto: Alì, mi dici se qualcuno nel palazzo affitta un posto auto? (Un posto auto, in questo quartiere, costa mensilmente quanto una casa intera a Genova: se mi chiamassero a parlare di gentrificazione, saprei da dove iniziare senza dover menzionare gli hipster).
Sono uscita con due numeri di telefono forniti dal portinaio: il primo apparteneva a un signore sguazzante nella gentrificazione; la seconda, V., in linea dalla Sardegna, ha ascoltato la mia richiesta con la pazienza dei giusti, ci ha ragionato un po’, poi mi ha risposto: Non so ancora se voglio affittarlo quel posto, fa parte di una storia famigliare, ma nel frattempo puoi usarlo gratis: io credo al buon vicinato.
Avrei voluto gridarle Grazie, sei un segno, ti ha mandato il karma, ti voglio benissimo e so che faccio bene a volertene prima ancora di averti visto, ma un guizzo di lucidità mi ha bloccato: magari all’altro capo del telefono avrebbe pensato che ero una povera squilibrata, e in quel momento avevo davvero bisogno che credesse alla mia affidabilità. Quindi ho ringraziato, spiegato sommariamente chi sono e cosa faccio e constatato con sollievo che talvolta la vita fa il giro: quello che dai in qualche modo ritorna.
Così, parecchie settimane dopo quella telefonata, mentre andavamo alla riunione di condominio, la prima a cui avessi mai partecipato, V. mi ha spiegato cosa sono i millesimi: unità di misura, il palazzo vale 1.000. Per cui ovviamente quelli che ci servivano non potevano essere ne 250 mila né 2.500, ma una ventina circa: abbastanza per dichiarare valida l’assemblea e discutere della sua richiesta.
Ci siamo sedute in prima fila – nemmeno alle elementari mi ero mai seduta in prima fila, nemmeno a sentire Civati moderato da Cirri, nemmeno al concerto di Vasco quando avevo 16 anni – ed è stato subito chiaro che non ce l’avevamo fatta: nei palazzi di Milano i lobbisti possono essere peggiori che alla commissione europea. Il numero legale mancava, inferiore ai 500 millesimi: battaglia rimanda a settembre. Troppi gli assenti, troppe le deleghe affidate e delegati poi risultati assenti, ri-cedute in pacchetti a delegati terzi che a quel punto però avevano orientamenti opposti a quelli degli incaricati: e se funziona così nel mio palazzo, figuriamoci in parlamento.
Così, col voto sospeso e la battaglia per la giusta causa di V. in stand by, non m’è rimasto che restare a osservare l’ animale sociale che è l’assemblea condominiale: un magma di gente che si coalizza e si insulta in geometrie variabili e fluttuanti, versione metropolitana del coro greco, di crescendi in polifonia e spigoli pungenti.
Dieci minuti a cercare un presidente.
Chi lo fa questa sera?
Signor T, lo faccia lei, su.
No, io no, l’ho fatto tutto l’anno scorso.
E lo rifaccia.
Ho detto di no, non ne ho voglia.
Ma su, cosa le costa, quest’anno non si è ancora nemmeno depilato le gambe!
Risate a fondo sala. Resistenza passiva del signor T. Condòmini che si nascondono dietro al programma, come durante le interrogazioni a sorpresa al liceo.
Basta, ora se non viene fuori nessuno tiriamo a sorte.
Rumore di una porta che si apre: il tizio del negozio al piano terra, in ritardo. Il signor T. si alza.
Piuttosto che sedermi vicino a questo, faccio il presidente.
Risate distensive: l’idea di fare il presidente aveva davvero terrorizzato parecchi.
Sei punti da discutere, più varie ed eventuali. Due saltano per assenza del numero legale di millesimi, due riguardano soldi da spendere.
Basta coi Mav. I mav costano. Abbiamo 2 mila euro di Mav inevasi, e perché dobbiamo pagarli, eh, perché? Ma siete pazzi, io non li pago i vostri Mav, pagateli voi.
No signora, guardi che la cifra non è quella, c’è gente che paga col bonifico, per quello che risultano inevasi.
Io non li pago, io non li pago i vostri Mav: è un’insensatezza.
Signora, non li sta pagando: è che qualcuno salda le rate cash, per quello risultano inevasi.
Appunto, io non li pago, ma perché li devo pagare io i vostri?
Signora non li sta pagando!
Appunto, e non voglio iniziare a farlo.
Signora, ne abbiamo discusso un’ora e mezzo l’anno scorso, ma che problema ha? Non li sta pagando, lo capisce o no?
E lei come se lo ricorda che ne abbiamo già parlato? Io non li pago i vostri Mav!
Signora, lei è pazza, ma cosa vuole, ma la smetta!
Io non li pago, ve lo dico.
Signora, ma vada a quel paese!
Sulle mie ginocchia languono dimenticati i compiti degli studenti che pensavo di correggere per ingannare il tempo prima del voto sulla richiesta di V.: mica potevo saperlo che fosse così divertente.
La pizzeria fa un odore terribile (a me, da quando m’hanno tolto il glutine, a dire il vero pare un profumino…)
Bisogna che tengano chiusa la porta.
Chi li conosce? Andateci a parlare.
Se posso pevmettervi, faccio l’avvocato a Londva. Pavlave non serve: svriviamo una letteva. Se non li denuncia il condominio, lo facciamo noi.
Dopo scriviamo la lettera, prima parliamoci.
Vipeto, c’è una violazione del codice: il nostvo inquilino lamenta un odove tevvibile.
Ma lei dove abita, scusi, in che palazzina?
Ah, quella dove c’è la signora col cane.
Vogliamo parlare dei cani? Questo palazzo è pieno: poi quelli li lasciano soli e questi abbaiano.
Io non li sento mai, a dire il vero. Nella mia scala ce ne sono tre: mi fanno abbastanza simpatia quando li vedo. Ma la lobby del cane deve essere potentissima: due cocker, un bastardino, poi quel cane lungo lungo, quello grigio, quell’altro là…
Ma il proprietario del lungo lungo quanti millesimi ha scusi?
Già e poi c’è l’annosa questione dell’appartamento del primo piano. Il proprietario è morto senza eredi: e ora chi le paga le spese del condominio arretrate?
Vero, come si fa a recuperarle?
Bisognerebbe vendere l’appartamento, ma non è a norma, non lo vuole nessuno, finirà all’asta.
Frenetica consultazione delle tabelle millesimi. Da parte mia: ora che ho imparato cosa sono, vado pazza per i millesimi.
Ma che problemi ha l’appartamento, che lo vuole nessuno?, sento dire dalla mia voce
Lasci stare, è un casino, la signora ha tirato giù tutti i muri, non le piacevano le pareti.
Ah, come me – è ancora la mia voce. Non è che si può vedere? Cioè, se non lo vuole nessuno, eh.
Io ho 11 millesimi. Se prendessi l’appartamento fantasma potrei arrivare sicuro a 23 almeno.
E se facessimo una festa in cortile? – sono ancora io.
Siamo seri su, l’avvocato non verrà mai. Non vorrà mai.
Ma facciamola, è carino.
Possiamo passare alle varie ed eventuali, per favore?
Ma la festa? Posso organizzare la festa?
Le varie ed eventuali, su, è mezzanotte.
La festa la prossima volta, ok. Magari nel frattempo avrò fatto un crowdfunding per l’appartamento fantasma. E col potere dei miei millesimi potrò organizzare un party.
Adesso ho infine capito a cosa servono.